Università Roma Tre – Accademia di Belle Arti di Roma
Dottorande (XXXVIII ciclo)
Chiara Mu
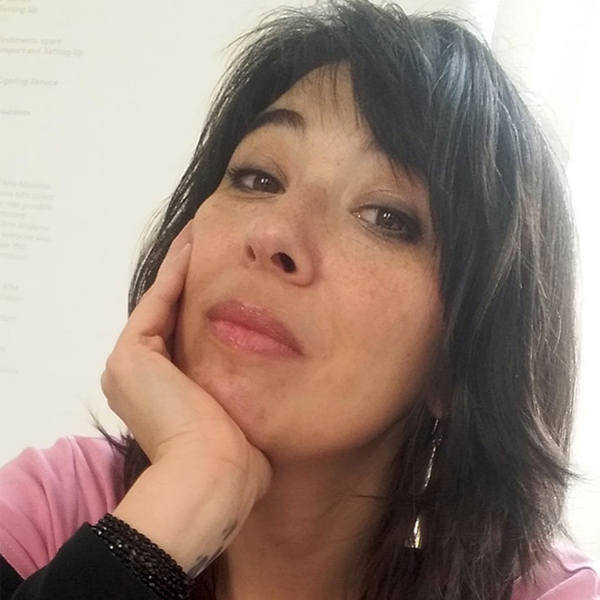
Le problematiche etiche della Performance Uno-a-Uno: come mettere in pratica modalità di cura abbracciando rischio e consenso quali parti integranti dell’esperienza estetica. – La ricerca proposta verte sulla messa a fuoco, teorica e pratica, della dimensione etica che definisce l’incontro tra artista e partecipante all’interno di eventi dal vivo, in cui immanenza e interazione rendono evidente l’esito concettuale dell’opera solo dopo la sua conclusione. Nel porsi il problema di come sia possibile dare il proprio consenso a partecipare di un’opera che è costituita da dinamiche relazionali imprevedibili (poiché in divenire), questo progetto di ricerca esplora i confini esistenti tra Arte Relazionale nell’ambito della Performance Art, l’Estetica dell’Embodiment (o Filosofia del Corpo) e gli studi sulla spettatorialità live. L’intento è comprendere come garantire, da parte dell’artista e delle istituzioni d’arte coinvolte, un ragionevole grado di cura nel presentare opere che possono comportare un possibile rischio di destabilizzazione, sia psicologica che fisica, per chi partecipa. A questo fine è prevista la realizzazione di tre performance uno-a-uno, la cui raccolta di feedback tramite questionari per i partecipanti mira a confutare o rafforzare la tesi esposta.
Da artista e ricercatrice del medium attiva negli ultimi vent’anni, sostengo che l’opera possa determinarsi come esperienza estetica solo se chi la vive accetta di ri-definire continuamente la gestione del contesto, accogliendo appieno l’imprevisto, seppure a volte foriero di conflitto. Questo assunto vale anche per chi l’opera l’ha concepita e la esperisce condividendola, ogni volta, con qualcuno che non può conoscere e di cui non può fino in fondo prevederne le azioni.
Chiara Mu (Roma, 1974) – Artista e ricercatrice che risiede a Londra dal 2017. Diplomata in Scenografia ad ABAROMA (1996-2001), ha conseguito il MFA presso il Chelsea College di Londra (2006-2009) ed è attualmente dottoranda presso l’Università RomaTre in consorzio con l’Accademia di Belle Arti di Roma (2023-2025), studiando le problematiche etiche che si riscontrano nelle performance uno-a-uno con l’intento di riconfigurare le pratiche di cura abbracciando rischio e consenso quali parti integranti dell’esperienza estetica. Ha ideato e curato con Paolo Martore per il pubblico italiano il libro Performance Art: traiettorie ed esperienze internazionali (Castelvecchi, 2018): una raccolta di saggi di artisti e autori stranieri mai tradotti prima. Ha esposto il suo lavoro nel corso degli anni in spazi no-profit britannici e italiani, tra cui “Cambridge Artworks Gallery” a Cambridge (2007, UK), “Five Years Gallery” e Yinka Shonibare Guest Projects Space a Londra (2009), e Condotto C a Roma (2009-2010). Ha esposto inoltre alla galleria Edieuropa – Qui Arte Contemporanea (2011-2012) e AlbumArte di Roma (2015), Bibo’s Place a Todi (2015), all’Auditorium – Fondazione per la Musica (2016) e al Museo Macro (2019) entrambi a Roma; con CIAC – Museo d’Arte Contemporanea di Genazzano (2014, Roma) e con la Fondazione Pietro e Alberto Rossini in Brianza (2015-2016). Ha prodotto performance per i Comuni di Venezia, Milano e Napoli e ha condotto laboratori sulla performance e sulle metodologie artistiche per le Accademie di Belle Arti italiane (di Roma, Bologna e Firenze). Ha inoltre collaborato come docente e tutor con il team di Palazzo Strozzi Education (2018), con la Yunnan Art University (Cina), il Saci Art Center di Firenze e l’Università di Milano Bicocca.
www.chiaramu.com – chiaramu@gmail.com
Dottorande (XXXIX ciclo)
Martina Macchia

L’indagine si focalizza su realtà progettuali ibride radicate in contesti extraurbani e periferici. Attraverso le numerose esperienze di artiste e artisti che decidono di abitare i margini, facendo interagire la dimensione creativa con quella militante, questi luoghi si delineano come un reticolato plurale, all’interno del quale l’azione sociale e l’esperienza collettiva del fare arte trovano terreno comune entro cui svilupparsi.
Attivando e valorizzando ciò che si trova fuori dal centro è diventato possibile riappropriarsi di quegli spazi definiti da Gilles Clément come residuali: paesaggi alternativi, derivati dal progressivo abbandono delle attività antropiche, che creano un bacino per la costruzione di comunità multispecie.
La ricerca si propone, attraverso l’interazione metodologica di alcune tematiche centrali nel contemporaneo, tra cui la marginalità come valore culturale e l’antispecismo, di individuare, a partire dall’analisi di alcuni case studies sul territorio nazionale, prospettive teorico-pratiche comuni, volte allo sviluppo di progetti il cui cardine è l’attivazione di luoghi residuali e decentrati rispetto ai maggiori centri di produzione culturale.
Martina Macchia (Giulianova, 1997) è curatrice e dottoranda presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’Università di Roma Tre. Dopo la Laurea Triennale al DAMS di Roma Tre e un periodo all’estero presso l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, ha conseguito il Diploma di II livello in Didattica e Comunicazione dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Roma.
La sua ricerca indaga i rapporti tra mobilità, produzione artistica e territorio, con particolare attenzione alle interferenze con il non umano. Lo studio della questione animale e dell’antispecismo in relazione all’arte si è consolidato nell’attività a RAVE East Village Artist Residency, di cui è parte del Comitato Direttivo e con cui collabora dal 2022. Tra le progettualità attivate all’interno di residenze per artist* emergono l’esperienza a Guilmi Art Project, dove ha curato la residenza-studio Rosalba. Lo spazio cangiante, e la restituzione della residenza del duo UCCI UCCI presso l’Istituto di Cultura Italiano di Colonia.
Attualmente collabora con diverse riviste tra cui “Animot. Studi critici sull’animalità”, “E.T. Zine” e “Impure. Journal of Art and Anthropology”.
macchia.martina@outlook.it
Dottorande (XXXX ciclo)
Aleksandra Anna Czuba

La ricerca per la tesi dottorale si focalizza sui potenziali epistemologici della comunicazione di cinematografie nazionali nel contesto dell’Europa centro-orientale, intesa sia come concetto geografico che geopolitico, nel periodo del regime comunista e della trasformazione in democrazie, in prospettiva di studio sociologica, antropologica e psicologica. Il progetto indaga i modelli culturali formati da usi, costumi, valori, tabù, atteggiamenti, espressioni iconiche, mode, ruoli e archetipi che forniscono una base per la conoscenza di una determinata realtà storica e i suoi aspetti più peculiari. Con l’obiettivo di ampliare la coscienza interculturale e contribuire alla mediazione tra cultura europea occidentale e orientale, ostacolata per decenni dalla cortina di ferro, si analizzano opere cinematografiche a esclusione di opere di propaganda o alquanto censurate per indagare l’importanza narrativo-espressiva del cinema nella formazione di immaginari collettivi e per comprendere il loro valore etnografico nella cultura visiva est-europea.
Aleksandra Anna Czuba – Ola Czuba (Polonia, 1984) – Artista visiva e dottoranda del XL ciclo in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza all’Università Roma Tre in consorzio con l’Accademia di Belle Arti di Roma (2024-2027). Diplomata in Arti Multimediali all’Accademia di Belle Arti di Roma con tesi sul tema dello spazio simbolico del femminile nelle opere dell’arte contemporanea e con un lavoro di produzione – la performance per video Tableau I. Curatrice della sezione dedicata all’arte contemporanea della collana Nuovo Lessico Critico, Castelvecchi (2021-oggi) – autrice dei saggi tematici sulle opere contemporanee nei volumi Rivoluzione (2021), Utopia (2023) e Identità (2025). Nel 2021 ricercatrice – Junior Scientist – nell’ambito delle attività del progetto europeo HORIZON2020 EU4ART_Differences – Work package 4. Ha esposto i suoi lavori in varie sedi tra cui PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, Short Theatre – Mattatoio Atelier a Roma, Palazzo Venezia a Roma, Scuderie Aldobrandini a Frascati, Palazzo Candiotti a Foligno, MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Stichting Centrum Beeldende Kunst a Rotterdam, Palazzo Ducale a Tagliacozzo, Casa Vuota a Roma, Museo Pietro Canonica a Roma.